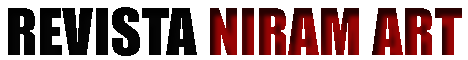Traduzione: Miriam Caracchini
Héctor Martínez Sanz: Peter, è un gran piacere per noi saperti a Madrid e di potere condividere e avere il piacere di presentare il tuo progetto Polyfonías. So che non ha niente a che vedere con il dadaismo, ma, la prima volta che ho sentito parlare delle Polyfonías mi è venuta in mente la cosidetta Poesia Simultanea, polifonica, che facevano Tzara, Janco e Huelsenbeck nel Café Voltaire. Soprattutto per tre aspetti: il lavoro in trio insieme a Mark Solborg e a Salvador Vidal, la mescolanza di lingue e l’importanza del suono, sia nella parola che nella musica. Vorrei incominiare domandandoti se hai preso in considerazione dei riferimenti, delle letture, come questa che ho appena menzionato, quando hai creato le Polyfonías o se nascono dalla tua esperienza diretta e personale della poesia?
Peter Wessel: Senz’altro mi sarei divertito molto con Tzara e i suoi complici dadaisti nel Café Voltaire. Condivido con loro lo spirito iconoclasta, il senso dell’humor sarcastico (che i danesi dominiamo bene) e –soprattutto- l’interesse per la poesia sonora. Ma il mio punto di partenza e i miei riferimenti sono diversi. La pietra d’angolo della mia poesia è la parola vernacolare con tutti suoi succhi, il suo colore e significato. Le parole non sense, senza senso, mi possono divertire e le monosillabe sono utili per dare voce e colore alle note musicali nel canto scat del jazz, ma non mi servono nella mia poetica. E, che lo voglia o no, vengo da una tradizione nordeuropea, cioè, pragmatica. La cosa –anche se incomprensibile- deve funzionare.
Quando dico che sono arrivato alle Polyfonías in forma organica –che Polyfonías è poesia translinguistica organica –mi riferisco a che sono cresciute dentro di me in una forma semincoscente man mano che mi stavo immergendo in nuove culture ed ho assimilato la forma in cui si esprimono. Lasciando la musica –una melodia che credo di ascoltare e che uso come un compositional conceit- nel comporre le parole, intervengo solo il necessario perché il mio pubblico non si perda completamente, così come cerco di trarre il massimo rendimento dai riferimenti interculturali, ma senza la fatica di trovare un senso al senso razionale della parola. Questa tecnica di abbandonarsi alle esigenze della musica è molto simile alla tecnica compositiva delle forme classiche della poesia con metrica e rime fisse. Infatti, sospetto che è il verso libero che ha permesso al linguaggio discorsivo e razionale di scivolare nella poesia con due nefaste conseguenze. Una, che molta gente crede che la poesia deve trattare di un tema ed essere comprensibile, e due, che si suppone di potere scrivere poesia senza prima acquisire il mestiere.
[…] seul “le petit comité”/ the barbershop quartet of my four voices, / mis / cuatro idiomas, quatre langues, / pueden lograr ce fameux “dérèglement de tous les sens” / that Rimbaud called for […] dico in una polyfonía. Ed è certo: la musica mi salva spesso da una pericolosa tendenza a filosofare. Ma poetry shouldn’t think, it should make you think, think and feel (la poesia non deve pensare, deve far pensare, pensare e sentire). Se lo dico prima in inglese è perché la definizione mi è venuta necessariamente in questa lingua, e senz’altro il suo senso giunge più profondo in inglese grazie al suono e al ritmo della frase. Il musicista e il pensatore lottano costantemente in me, ma mi fido di più del primo. Sempre ascolto prima la musica nel discorso di chi parla. Impiego molto tempo prima di iniziare a dare un senso alle parole. Ovviamente mi perdo molti discorsi dal punto di vista dell’informazione concreta. Ma credo che in ogni modo mi rendo conto di molte cose. Di altre cose ad un altro livello di comprensione.
Può essere che anche entri in gioco uno strano dono che ho. Fin da molto piccolo ero in grado di trascrivere con molta precisone i suoni delle lingue che ascoltavo intorno a me. Voglio dire che prima di conoscere il significato di una parola in danese, inglese o francese sapevo come sillabarla con la grafia propria di ogni lingua. Riconoscevo “intuitivamente” l’aspetto grafico che doveva avere una parola danese, francese o inglese. Lo stesso mi è successo, già in età adulta, con il castigliano. Ovviamente l’“immagine” sonora di una parola in castigliano non è molto distante dalla sua immagine grafica, ma, come sanno bene gli spagnoli, da tempo la pronuncia inglese si è separata dalla sua ortografia. Quando scrivo le parole già mi suonano e, mi lascio guidare dal loro suono, non noto quando salto da una lingua all’altra. È come guidare da un paese europeo all’altro: non ci sono frontiere o dogane tra le mie quattro lingue.
H.M.S: In un articolo ti ho soprannominato “il giullare di Lavapiés”, per concepire la poesia come nel Medioevo: una rappresentazione orale con musica, o, come ho scritto in un articolo, “un nomade giullare nel suo spettacolo poetico-musicale rinventando il latino nelle varie forme delle lingue romanze mentre suona la zampogna o la viella”. Ti sembra acertada la comparazione?
PW: Mio padre adorava cantare e aveva una bella voce. Anche mio fratello cantava ed era un attore per natura. Io volevo essere un musicista, ma dato che in Danimarca ogni atto sociale: matrimoni, compleanni, cresime, incontri richiedono delle canzoni appositamente scritte per l’occasione, a me toccava sempre il ruolo di lyricist, come si dice in inglese, già all’età di 12-13 anni. Per l’anno nuovo di solito facevamo un cabaret stile chirigota nel quale prendevamo in giro la famiglia e gli amici, e nessuno dubitava che i testi li scrivevo io. Ho anche provato a scrivere degli inni religiosi per fare piacere a mio padre che ogni domenica andava a messa, soprattutto perché era un’occasione per cantare, credo. Come vedi, già dall’infanzia vivevo in un ambiente un po’ simile a quello dell’Europa del XII e XV secolo. E anche i miei spostamenti si realizzavano con la lentezza di un epoca in cui l’unico mezzo di trasporto via terra era il cavallo o l’asino. Ovviamente non mi sono privato di auto, treni o aerei, ma non mi piace lasciare un paese fino a quando non ne faccio parte, fino a quando non mi sia immerso nella sua cultura. Ho una figlia francese di 37 anni vivo in Spagna dal 1981, poiché mi sono sposato con una spagnola da 25 anni. Ho vissuto in California alla fine degli anni ’60 –durante la youth revolt, gli anni hippies- e la poesia nordamericana, il jazz, action painting, movies, e la cultura popolare sono stati decisivi per la mia formazione personale e artistica. La vita come road movie è un mito genuinamente yanqui e per me non rappresenta nessuna eresia dire che sono tanto minstrel che menestrello (anche se temo che per la facoltà dove sto facendo il mio dottorato in arte medievale con una tesi sull’iconografia ludica nell’arte romanica aragonese si lo è).
Infatti, suono il banjo con cinque corde, uno strumento musicale che nella cultura nordamericana ha avuto un ruolo molto simile al laúd e alla zampogna nell’Europa del Medioevo. Nell’alto medioevo poca gente sapeva leggere e scrivere e la gente comunicava con lingue vernacolari, cioè le lingue “volgari” del ceto basso. Ho detto che la parola vernacolare è la pietra d’angolo delle mie Polyfonías. Credo fermamente nell’importanza del fatto della differenza culturale. Sono trent’anni che insegno inglese come lingua straniera in Spagna. La pronuncia che si insegna si chiama received English pronunciation ed è una strana lingua senza nessuna patria. È chimicamente pulita, asettica, senza nessun marco di origine (anche se in realtà si suppone che l’inglese della Regina d’Inghilterra; un più chiaro esempio di imperialismo linguistico è impossibile). Una lingua di robots, ma ovviamente perfetto per la comunicazione internazionale. E serve per questo. Per spiegare come aprire una scatoletta in qualsiasi parte del mondo ti trovi. Ora, credere che serve per la poesia è come cavar sangue da una rapa.
Le parole che utilizzo nelle mie Polyfonías sono state tutte “contaminate” dall’esperienza. Le ho apprese da dentro. Dal loro grido e sussurro originario. E non mi permetto di usarle fintanto che non siano maturate in me e ne conosco tutti i sapori. Fino a quando non escono dalla mia bocca o dalla punta delle mie dita per pura necessità. Perché corrispondono a quello che sento e ascolto, perché questa parola è le mot juste.
Nella mia tavolozza si sono depositati con il tempo i colori di quattro culture: la danese, la nordamericana, la francese e la spagnola. Ho vissuto nove anni a Mallorca e capisco bene la loro lingua, ma mia moglie, che ho conosciuto in quell’isola, è della Rioja ed ho solo raggiunto il contatto diretto e fisico con molte poche parole mallorchine. Finché non parli la lingua del paese dove vivi con naturalezza e senza pensarci continuerari ad essere un turista. Comunque, ci sono parole di alberi, piante, insetti, fiori, venti e cibi che sono propri della cultura baleare e che ho conosciuto lì per la prima volta. Anche queste ci sono nella mia tavolozza ma finora non ne ho incorporata nessuna.
H.M.S: Hai iniziato con la musica. Sei un grande amante del Jazz e del suono del vecchio vinile. Infatti, ci presenti le Polyfonías in un CD-Libro e il suo disegno ricorda i dischi di vinile. La musica, senza dubbio, attraverso Solborg e Vidal, ha una forte presenza ed è un gran peso in questa opera, non come un accompagnamento di fondo per la parola, ma come forza espressiva. Parola e musica si confondono nel suono della poesia Polifonica. Succede lo stesso tra te, Solborg y Vidal? Voglio dire, scompare tra di voi la differenza tra il musicista e il poeta o, è di più, solo ci sono tre musicisti che insieme formano il poeta?
PW: Il concetto di Polyfonías deve molto al jazz; una musica, un life style, una forma di essere che è stata determinante per la mia vita. È un’arte ibrida che riunisce elementi di varie culture musicali: inni religiosi inglesi, marce militari francesi, pasodobles spagnoli con acento caraibico. Dall’Africa traggo una percezione tonale diversa dall’affinazione diatonica europea che incontrandosi con questa ha creato la nota blue caratteristica del blues con i ritmi e il concetto collettivo e rituale della musica. Quello che produciamo con Mark e Salvador non è jazz musicalement hablant –per lo meno non appartiene alla mia definizione di jazz- ma la sua anima e la sua organizzazione si è jazz, e il seno più radicale, cioè, originale, della parola. È un’opera collettiva nella quale le lingue e le improvvisazioni stumentali si intrecciano in un tappeto sonoro. Non è free improvisation, dato che i testi non variano e ci sono motivi e sketches melodici associati ad ogni polifonia, ma come in ogni buona conversazione, ci ascoltiamo l’uno con l’altro e sempre c’è qualcosa di nuovo e sorprendente nella risposta. Quello si, la parola in Polyfonías non smette mai di essere parola: è parlata, con più o meno forza e intensità, ma parlata, non cantata. Ha sempre un significato, anche un significato non compreso o non capito, e si deve ascoltare, distinguere. In ciò siamo tutti d’accordo, e Mark e Salvador fanno molta attenzione a non coprire la mia voce.
H.M.S: Solborg si mostra minimalista e Vidal improvvisatore, questa differenza tocca al tono delle Polyfonías, alle parole che scrivi? Prima si compone il poema e poi la musica, prima la musica e poi il poema, o insieme?
PW: Scrivo i miei testi polifonici come qualsiasi poeta che si siede a scrivere su di un foglio bianco o uno schermo: in solitudine. Poi lo leggo e lo spiego ai due musicisti che propongono delle idee. Dopo rileggo il poema, già in dialogo con uno o entrambi gli strumenti. Così è il processo ideale. Ma, dato che Mark vive in Danimarca utilizziamo anche la tecnologia moderna: a volte mando un testo a Mark e compone un tema che poi mi manda come archivio sonoro con una partitura. Poi mi riunisco con Salva e incominciamo a lavorare in base alla “brutta copia” di Mark. La creazione della polyfonía finisce quando tutti e tre ci incontriamo per provare nella città in cui attueremo. Mark è di una generazione più giovane di quella di me e Salva e senz’altro ha beveuto a delle fonti differenti dalle nostre. È un compositore e musicista di jazz dell’ambiente di Bill Frisell, Marc Ducret, Cris Potter, Pierre Dørge, e suona la chitarra e una parafernalia di elettronica, keyboards y laptop incluse. È un compositore estremamente delicato e i suoi temi per il nostro progetto forse ti possono sembrare un po’ minimalisti, ma combina bene con Salvador che viene dal mondo della musica classica, ed ha uno speciale appetito per i compositori sperimentali del xx secolo. Mark non è meno improvvisatore di Salvador, ma siccome suona degli strumenti armonici ha un ruolo più strutturale di Salva che suona uno strumento melodico che, anche se acustico e di legno, nelle mani di un espressionista con i polmoni di Salva, può suonare molto forte, nonostante il suo lato straordinariamente lirico e dolce.
H.M.S: La polifonia musicale ha rappresentato una vera rivoluzione contro la monodia nel XVI secolo, sia per le voci che per gli strumenti. In poesia ci sono stati molti tentativi di creare qualcosa di simile, dal simultaneismo di cui ho detto prima, al frammentarismo, alla diversità di voci all’interno di uno stesso poema rispetto al monologo dell’io poetico… Avendo la musica e la poesia un’origine comune e una storia unita, ed essendo la polifonía qualcosa già classico nella musica, dicci la tua opinioni, come autore polifonico, e perché nella poesia continua ad essere un sintomo di avanguardia e novità? Perché non si assesta?
PW: Léonin y Perotin, compositori e cantanti della Cattedrale di Notre Dame di Parigi, svilupparono il canto polfonico a partire dalla monodia degli organum nel XII secolo, ma esistono esempi di messe polifoniche nella Cattedrale di Westminster già nel XI secolo. I mottetti dell’ Ars antigua erano delle composizioni per due, tre o quattro voci, ognuna con un suo testo. Mottetto viene da mot, che in francese vuol dire parola, e i mottetti erano spesso multilingue, mescolando spesso dei testi religiosi cantati in latino e dei poemi d’amore cantati in francese. Il crescente uso di strumenti armonici alla fine del XVIII secolo, fu una delle cause dominanti per finire coni mottetti, ma è importante ricordare che la polifonia nacque come un modo di cantare differenti testi a più voci. Erano, per dirlo in qualche modo, degli arrangiamenti musicali di testi preesistenti scritti in diverse lingue e rappresentavano una sintesi perfetta tra musica e poesia, quindi si faceva molta attenzione a che le parole si potevano distinguere (anche se certamente poteva essere difficile poiché le varie voci si cantavano simultaneamente). Un’arte a sua volta polifonica, multitestuale e multilingue.
Il principio polifonico ha continuato ad esistere in relazione alla poesia, quello che succede è che il canto polifonico come si manifestò nei mottetti ha perso la sua attualità, o, diciamo la sua raison d’être. Ma di poesia polifonica –multilingue o no, ma polifonica in qualsiasi caso- ce ne sono molti esempi e la prima, d’avanguardia nel suo momento, certamente, è già classica, anch’essa. I suoi autori, i poeti polifonici della poesia moderna, si possono dividere in due gruppi. Quelli che, allo stile del drammaturgo T. S. Eliot, inventano personae esteriori –è il gruppo, senz’altro, più numeroso- e quelli che fanno parlare le sue personae interiori, come Pessoa. Io mi colloco in questo secondo gruppo, anche se ammetto che Eliot è stato uno dei miei autori di referimento durante i miei anni sturm und drang e non ho mai smesso di leggerlo, anche se oggi lo leggo con meno frequenza.
Gli esperimenti poetici dei dadaisti li vedo molto meglio come saggi polifonici musicali, o forse dovrei dire delle performances rumorose, bruitistes, polifonici. Svuotavano le parole di senso ed usavano delle parole senza senso e onomatopee per esprimere la loro intenzione di rinunciare ad un linguaggio che, con le parole di Hugo Ball, “il giornalismo ha finito e ha reso sterile”. Credo che negare alla parola il suo pane, negarle la sua funzione di essere portatrice di significato, equivale a sottrarle la sua ragione d’essere. Credo che una nursery rhyme riesce a polverizzare il linguaggio della ragione –il linguaggio giornalistico di cui parla Hugo Ball- con la stessa efficacia e in un modo molto più poetico e divertente che i poemi fonetici dadaisti. Prendiamo, Humpty Dumpty sep-sapa-sep / Humpty Dumpty dideli-de / rop waka dokti flat pantu fli ten / nok tiki Humpty faluti kas tot. Perché i poeti dadaisti persero il loro tempo ad attaccare il linguaggio dei giornalisti e dei politici? Probabilmente ciò è dovuto all’epoca in cui vivevano: la delusione della Grande Guerra, il senso di sentirsi ingannati. Pensa ad Apollinaire. La sua arte è un compendio confuso di idealismo, di patriottismo e inganno.
In fin dei conti credo che il problema che menzioni nella tua domanda: il perché il principio polifonico nella poesia “non si assesta e continua ad essere avanguardia quando nella musica è qualcosa di già classico perfettamente assunto” è un falso problema. Ha a che vedere con una debolezza critica tanto consolidata che è diventata un dogma: il volere utilizzare per la poesia la stessa misura della prosa discorsiva. E anche per la mancanza di coraggio da parte dei poeti di rivendicare la loro arte come un linguaggio unico –come un luogo dove nessuna parola è straniera. Ammiro moltissimo il quadro di Magritte “Ceci n’est pas une pipe”. Dice tutto. Per me è un’opera di critica d’arte fondamentale e un’opera maestra precoce di arte concettuale e dovrebbe essere considerata un’esempio per i poeti e i critici della letteratura come per il mondo dell’arte plastica. Effettivamente, la pipa che ha dipinto il surrealista belga non è una pipa, ma una superficie piana con i colori e il contorno di una pipa. Siamo d’accordo. Ma, è il fatto che non puoi fumare in quella pipa una ragione per eliminare la forma di una pipa e quello che con essa associamo del nostro vocabolario di pittori? Al contrario, ci offre l’opportunità di inserire la forma della pipa in ogni tipo di nuovi contesti e avventure pittoriche nei quali non siamo abituati a vedere questo indissolubile simbolo di pazienza e tranquillità. La morte di Dio, l’invenzione della macchina fotografica, la pubblicazione de, L’interpretazione dei sogni e le altre scoperte filosofiche, scientifiche e tecnologiche dell’appena finito XX secolo, liberò gli artisti dal ruolo di illustratori e potevano dipingere degli oggetti familiari senza preoccuparsi d’altro che il loro contesto, la loro realtà pittorica.
Sicuramente i dadisti crearono un brouhaha sociale considerevole, ma credo che la loro influenza è stata più importante per lo sviluppo delle nuove musiche che per la poesia. Dopo tutto, quando svuoti le parole di significato con che rimani? Con degli effetti sonori. Mi sembra più interessante la poesia concreta e visuale che è stata molto più importante per il rinnovamento della poesia scritta e –di conseguenza- come “partiture” per la poesia orale.
H.M.S: Lo scrivere “Polyfonías” con “y”, è dovuto all’intenzione di differenziarsi dal resto delle polifonie musicali e letterarie, come un nuovo genere diverso da quello già conosciuto?
PW: Il caso ha avuto sempre un ruolo importante nel dadaismo, e la “y” di Polyfonías accadde per pura casualità e pensai che si dovevo renderle omaggio lasciandola. Io scrivevo sempre “polifonías” così, con la “i”, in castigliano corretto. Ma quando Mark Solborg, che è danese, disegnò la copertina, si sbagliò e scrisse la parola metà in danese –con y –metà in castigliano- con l’accento sulla “i” e terminante in “as”, quando in danese si scrive con “er” alla fine: “Polyfonier”. Sua madre è argentina, non escludo che si trattasse di un Freudian Slip. Dato che sempre insisto sulla necessità di mantenere la purezza linguistica e ortografica delle parole nei miei poemi translinguistici, anche se sono un grande difensore della mescolanza delle relazioni tra i popoli, ho pensato che non potevo trovare un posto migliore per rompere la mia regola nel titolo e nel nome della mia nuova poesia. Inoltre, in danese la “y” ha un suono più grave e meno stridente della “i”, e comprendo perfettamente William Blake quando chiama “tyger” alla sua “tiger” nel suo famoso poema sulla tigre. Chi non si rende conto che il tyger è molto più elegante, molto più degno e forte e ha un’aspetto più minaccioso nell’ambra degli occhi della tigre? Certamente non c’è dubbio che le Polyfonías hanno molti più colori delle Polifonie!
H.M.S: L’altro giorno mi hai commentato una citazione di Miles Davis che ho anche letto in una tua intervista con Antoine Cassar. La citazione dice:
“If you can’t hear what the blues is, don’t ask”. Possiamo applicarla alle tue Polyfonías? Mi riferisco, soprattutto, a che non dica “understand” ma “hear” accentuando il fatto del suono e della musica. Potrebbero esistere le Polyfonías senza di questi?
PW: Effettivamente credo che mi riferivo alla necessità di ascoltare, o alla capacità di ascoltare. Non ascoltare con la testa, ma con la pancia, come ha detto un’altro grande musicista di jazz. È meno banale di “ascoltare con il cuore”, anche se senza dubbio è a quello che si riferiva.
H.M.S: Sono più che sicuro che le tue Polyfonías si devono ascoltare. Ma possono anche essere lette nel modo tradizionale, senza la tua voce, senza la musica di Mark Solborg e di Salvador Vidal? Non perderebbero una parte molto importante?
PW: Poco fa parlavamo del tyger e del tiger. Ci sono delle cose che si possono ottenere con le parole scritte a seconda della disposizione del testo sulla carta, ma che non si sentono quando reciti il poema. È un’altra esperienza, anche se, rispetto alle Polyfonías senz’altro è secondaria. Chi ascolta solo sente una voce (la mia) e, generalmente, capisce molte delle parole, finisce con avere l’idea di avere capito tutto. È la mia impressione che la gente, ipnotizata dal dialogo tra la voce e gli strumenti musicali, dimentica sia che ci sono delle parole che non capisce che le sue eventuali cautele di fronte alla difficoltà del linguaggio poetico. Abbandonano i loro blocchi e pregiudizi e, portati dalla musica, iniziano a partecipare con la loro immaginazione. Credo che la cosa migliore è prima ascoltare le polifonie e dopo leggerle. Le due esperienza si complementano, per quello le abbiamo pubblicate como CD-libro.
H.M.S: Generalmente, al poeta che viene da altre terre –e nel tuo caso sono varie, non solo Danimarca-, di solito si chiede se conosce dei poeti spagnoli, quali ha letto, e quali ha maggiormente approfondito… ma dato che abbiamo evidenziato il ruolo della musica, ti chiederò, invece, da quali musicisti e compositori spagnoli, per esempio, i classici Sarasate, Manuel de Falla, Joaquin Rodriguez, Albéniz, o da quali stili come il canto flamenco e il canto jondo, la zarzuela, o da quali delle nostre musiche popolari, dalle sardanas alle jotas e muñerias, i pasodobles; quale è la tua impressione della nostra storia e tradizione musicale così tanto variata? Qualcuna potrebbe essere una compagna dei tuoi tuoi poemi?
PW: Certamente la Spagna ha una ricchezza musicale notevole e a quello contribuisce il fatto che ci sono molte regioni nella penisola iberica e nelle isole e tutti hanno saputo conservare la loro idiosincrasia, il loro vernacolo musicale, e quello malgrado il clima se non freddo o semplicemente assente, perlomeno incoerente e capriccioso della politica culturale ufficiale verso la musica in questo paese. Ascolto molta musica spagnola (che sollievo che almeno in questo contesto si può usare la mal amata–svalutata e respinta parola “spagnolo”!), specialmente la musica scritta per chitarra e piano. La mia musica spagnola preferita è il canto jondo, sia quella classica che quella più moderna di Morente, Mayte Martín e Miguel Poveda. Vivo accanto alla scuola di ballo e musica flamenca “Amor de Dios”. Credo che è una dei contributi più singolari e importanti delle arti sceniche di Spagna –senz’altro la più conosciuta fuori delle frontiere della Spagna –e ha dovuto fare una vita da nomade e senza praticamente sovvenzioni pubbliche! In Danimarca avrebbe avuto uno status di istituzione nazionale con un presupposto fisso. Scusa lo sfogo, ma ci sono delle cose quì che mi indignano moltissimo.
Per ritornare alla tua domanda, dirò che il dialogo tra cantante e chitarra nel canto jondo mi ricorda i miei dialoghi con Mark e Salvador. Forse soprattutto i miei dialoghi con Salva quando recitiamo in duo, como recentemente lo abbiamo fatto in “Enclave de Libros”qui a Madrid, dato che in questa occasione Salvador improvvisava quasi tutto. Facciamo sempre diverse prove e accordiamo certe cose prima del recital, ma una volta in scena ci sono molte sorprese. E sempre buone!
H.M.S: Nel poema manifesto delle tue Polyfonías, “Un idioma sin fronteras”, ci dici che “Dentro de mí / viven cuatro personas / each with their own voice / su propia / lengua / sa propre langue/ Hver med sit eget sprog / og sin egen stemme”. Dici la stessa cosa nelle quattro lingue –spagnolo, inglese, francese, danese-, con i loro diversi suoni, accenti e forza… e più avanti, aggiungi: “mirándome uno tras otro / en los espejos de feria del / danés, inglés, francés / y espagnol”. Non sarebbe meglio dire che non sono quattro ma è una sola persona che parla con la sua voce e la sua lingua? In fin dei conti, è solo agli altri che risultano quattro lingue diverse, quattro specchi che ti riflettono…
PW: Durante la sua presentazione del nostro recital in “Enclave de Libros”, la ricercatrice e traduttrice italiana Miriam Caracchini ha menzionato uno studio del teorico russo Mijhail Bajtin sul romanzo di Fiódor Dostoyevski e un saggio che l’eminente linguista Alfons Knauth ha dedicato alle Polyfonías per spiegare il mio uso di varie voci e il concetto di poliglottismo. Per Bajtin non esiste un “io individualista e privato; l’ “io” è essenzialmente sociale. Ogni individuo si costituisce come un collettivo di numerosi “io” che ha assimilato nella sua vita. Questi “io” s’incontrano nei linguaggi, nelle “voci” parlate da altri e che appartengono a fonti diverse (scienza, arte, religione, classe, ecc.). Queste “voci” non sono solo parole ma anche un insieme di credenze e di norme chiamato “ideologia”. Non staremo mai al di fuori dell’ideologia perché “parliamo con la nostra ideologia: la nostra collezione di linguaggi, di parole caricate di valori”.
È per questo motivo che l’analisi della lingua nella sua totalità concreta e vivente porta all’analisi translingistica, in altre parole, alla polifonia, all’insieme delle “voci”, non al semplicemente linguistico che offre una prospettiva monologica e astratta.
Alfons Knauth, professore e ricercatore dell’Università di Bochum, dice nel suo saggio sul progetto Polyfonías che “è altamente rappresentativo dell’espressione artistica della persona nomadica e mosaica moderna” e continua: “Nel contesto dei movimenti transculturali contemporanei e le migrazioni, il multilinguismo è diventato una caratteristica basica del linguaggio poetico. È un modo a sua volta naturale e artistico di comunicazione, che non è più marginale, essendo ogni volta più sostanziale. L’inglese può funzionare come una lingua globale per la comunicazione di un’informazione pratica, ma il dialogo tra una lingua materna e la lingua dell’altro è essenziale per la creazione e l’espressione di un’identità personale e cuturale”.
Credo che le loro osservazioni rispondono bene alla tua domanda. Personalmente posso aggiungere che ogni lingua delle quattro che “parlo a me stesso”, come ho l’abitudine di dire, corrisponde ad un’area diversa della mia personalità e dei miei interessi, anche se ha a che vedere con la situazione in cui mi trovo e la mia interfaccia con il mio interlocutore.
Per esempio, io e Miriam Caracchini ci siamo abituati a conversare in spagnolo anche se entrambi abbiamo vissuto molti anni a Parigi e lei è più fluida in francese. Inoltre ogni lingua tende a parlare dai differenti periodi della mia vita. Da ultimo è la mia personalità musicale che scopre le parole in funzione del loro colore, del loro sapore, della loro corporeità, del loro odore e ritmo. Ho solo una voce, non ho bisogno di altre per parlare il linguaggio polifonico della poesia. Perché in realtà tutta la poesia è multilingue, semplicemente non si sente quando il poeta si serve solo di una lingua.
H.M.S: L’allusione agli specchi mi ricorda i famosi specchi del Callejón del Gato, descritti da Valle-Inclán nelle sue “Luci di Bohemia”. Per Valle-Inclán, lo specchio deformante –concavo, convesso- era necessario per vedere la realtà e la tragedia spagnola che, a sua volta, era deformata alla semplice vista. Nel tuo caso, gli specchi della lingua, ti riflettono, ti deformano o ti riformano?
PW: L’effetto degli specchi deformanti che causano le traduzioni interne –un espediente tecnico che io chiamo glissandi, o “scivolamenti”, di significati tra le differenti lingue- finisce, insieme alla musica per formare vari strati- qualcuna comprensibile altre no, secondo le conoscenze e le esperienze di ogni udente.Possiamo vedere le parole come piccole scatole, lavagne o specchi. Se le vediamo come delle piccole scatole il loro contenuto invecchia, ma non cambia, se le vediamo come lavagne il contenuto si cancella quando aggiungiamo una nuova interpretazione, ma se sono degli specchi si possono riflettere tra loro e costantemente svelare nuovi significati. È quello che mi succede quando il significato che ho assegnato ad una parola in una lingua si riflette, o risuona in quella che è la sua supposta traduzione in un’altra. Per quello le traduzioni interne sono in realtà aparentes traducciones o traducciones creativas. Ma siccome tutte queste parole in differenti lingue sono anche le mie esperienze attraverso il corridoio del tempo –e vale la pena vedere qui il corridoio che si forma tra due specchi nei luna park- trasformano anche me stesso e i miei lettori o i nostri udenti. Nella polifonia “Flux” –fai attenzione al titolo- dico “And true: / Les femmes, / las mujeres, / women, / kvinder /har altid været, han sido / siempre, / mis mejores, y auténticas, / guías / for women are like trees / and where there are trees / there is water.” Le ripetizioni in differenti lingue di ”mujeres” sono traduzioni? Per me comunque no. E non sono ”mujeres”, come direbbe Magritte. Sono l’idea della feminilità vista dall’ottica di differenti culture (o perlomeno così le ho vissute essendomi sommerso in differenti culture). Per quello a volte uso l’epiteto di ”cubista” per le mie Polyfonías.
Ti ho dato la mia visione, la mia versione, del Callejón del Gato. Stiamo parlando di angoli e punti di vista. Vediamo quello che dice il professor Knauth dei miei specchi:
Le traduzioni intertestuali offrono una specie di linguistica contrastiva e creativa, poiché, invece di rivelare l’identico, rivelano il differente nel processo traduttologico: differenze di suono, ritmo, grammatica e significato che aggiungono un senso complementario o un senso antifrastico alle strutture monolinguistiche. Allo stesso producono un effetto di modulazione musicale. A parte le differenze all’interno delle combinazioni interlinguistiche, c’è un cambio costante nella quantità e distribuzione di espressioni idiomatiche e di elementi traslativi, nel ruolo che compie ogni espressione idiomatica, sia nella funzione di tradurre o di essere oggetto di traduzione. La stessa mobilità si trova nelle parole senza tradurre. C’è un “gioco costante di specchi cambianti”, come direbbe Borges.
H.M.S: Sono d’accordo in che la parola, la lingua, è insufficiente, rimane sempre qualcosa di indicibile, d’inesprimibile, che si perde sia nel parlare che nello scrivere. Molte volte ci capiamo meglio con i gesti o con gli sguardi, con un linguaggio non verbale e più universale. Il poeta, che usa le parole, lotta con la lingua per potersi dire senza cambiarla. È più facile questa battaglia dominando quattro lingue?
PW: Possiedo le quattro lingue delle culture nelle quali ho vissuto, ma come poeta ne parlo solo una: la lingua senza frontiere della poesia, il linguaggio del silenzio dal quale nascono tutte le lingue. La poesia è l’espressione dell’ineffabile e il poeta è l’alchimista della parola.
Un’altra cosa molto diversa, e molto positiva, è che la poesia multilingue tende ad incrementare interesse per le altre lingue, soprattutto per le lingue minoritarie, come il danese nel caso di Polyfonías. Attualmente insegno danese nella, Escuela Oficial de Idiomas, ed è meraviglioso sentire l’entusiasmo che gli alunni hanno per le lingue meno parlate a livello internazionale. Quando vado nella mia classe vedo un manifesto con la dichiarazione a favore della “lingua materna più due” sono completamente d’accordo. Può essere che sembri molto complicato che ci siano tante lingue in Europa, ma credo che la varietà culturale è una grande forza che vale la pena difendere e si deve iniziare con le lingue che costituiscono l’espressione dell’identità di ogni paese, e non soltanto di ogni paese europeo, certo; questa lotta per le lingue si deve avere in ambito mondiale. Sono convinto che la convivenza e la pace si conseguono attraverso la comprensione dell’altro. Dell’interesse e del rispetto per la sua cultura e la sua lingua. Come dice il professor Knauth in uno studio per la UNICEF che: cambiare e intercambiare le maschere linguistiche è la forma più genuina di comunicazione interculturale nella quale lo strano finisce per diventare qualcosa di condiviso.
Non mi interessa se le parole danesi nelle mie Polyfonías hanno l’effetto delle parole nonsense della poesia dadà e ricordano all’udente o al lettore che si tratta di un poema, che sta ascoltando o leggendo il linguaggio poetico ed meglio togliere il filtro della ragione il desiderio di capire attraverso la ratio. Infatti, qualcuno mi ha detto una volta dopo un recital che gli piaceva molto incontrarsi con queste parole “incomprensibili”.
“Si aggiungono al mistero poetico, alla magia della poesia”, disse “invitano a partecipare con la propria immaginazione”. Mi sembrò un’osservazione molto originale. Tankevækkende, come diciamo in danese. Comunque, mi fa piacere che la mia poesia serva anche a far si che la gente si interessi alla cultura del paese dove sono nato e che forse impari anche il danese, la mia lingua materna. Ha detto India Vera, la giornalista che mi ha intervistato per La libélula di Radio 3 dopo il nostro recital in “Enclave de Libros”, che Polyfonías è “per la gente Erasmus”. Un realizzato e non meno Tankevækkende.
H.M.S: Esempio stesso dell’insufficienza della parola è l’insufficienza delle traduzioni dei poemi. Perdiamo molto e guadagnamo molto poco nel tradurre un poema. Per un poeta polifonico non si presenta quel problema, non c’è bisogno di una traduzione?
PW: Effettivamente, un poema non si può tradurre nel senso tradizionale della parola. Credo che era Haroldo de Campos, il grande poeta, traduttore e linguista brasiliano, che disse che scrivere è tradurre. In qualsiasi caso, fu l’inventore del concetto della transcreazione, anche detto della traduzione creativa. L’idea è che un testo “creativo”, come può essere un poema, si deve ricreare nella traduzione. La traduzione sorgerà dall’incontro con la cultura della lingua alla quale si vuole tradurre. L’idea classica della “traduzione fedele” della traduzione “trasparente” dove si suppone che il traduttore riesce a non lasciare nessuna traccia rispetto al testo originale, solo serve per dei testi da manuali. “Un poema non è istruzioni per aprire una scatoletta”, ho detto in una intervista con l’anche poeta multilingue, il mio amico maltese Antoine Cassar. Ma nemmeno la traduzione creativa si può con il nostro tipo di poesia. Dice il professor Knauth nel suo saggio sulle Polyfonías:
La necessità interna di poliglossia è confermata dal fatto che i poemi multilingue non si possono tradurre. Al massimo è possibile una traduzione fittizia traducendo un determinato poema tetralingue ad altre quattro lingue, ma questo tipo di traduzione fittizia modificherebbe completamente la struttura linguistica e il senso dell’originale. Una traduzione multiple solo si può concepire come una “variazione” del poema originale. Una specie di “tema con variazioni”.
Il problema basico per la traduzione –anche “creativa”- di Polyfonías, poemi multilingue, è che non hanno come base una determinata lingua nazionale. Torno a citare il professor Knauth: Le opposizioni formali (non le tematiche) della lingua nativa e straniera, di norma e di deviazione, di lingua fonte e di lingua di arrivo sono diventate obsolete, includendo l’uso degli elementi tipografici corrispondenti di corsiva e normale. Non dico che Haroldo de Campos non lo avesse provato. Era un uomo di una creatività impressionante e con enormi conoscenze linguistiche. Comunque ti posso dire che ci sono dei poemi da lui tradotti che assolutamente hanno perso rispetto all’originale. Io credo che bisogna vedere le transcreazioni come dei poemi nuovi e autonomi e valutarli così.
H.M.S: Per finire, una curiosità personale. Durante l’ultimo anno, sono stato molto coinvolto nella promozione della cultura rumena internazionale, di dibattiti e libri, e soprattutto, di vari autori e artisti come, per esempio Costantin Brancusi. Una volta hai parlato di Costantin Brancusi come di una delle molte influenze nei tuoi lavori. Potresti spiegarci questa influenza che viene dal mondo della scultura?
PW: Sarebbe tentatore pensare che se menziono a Brancusi come influenza, questa ha a che vedere con l’aspetto cubista della mia tecnica “glissandi di significati” che abbiamo già commentato. Dopo tutto, solitamente si menziona il nome dell’artista rumeno in relazione alla storia del cubismo poiché in tutta la sua opera è soggiacente un punto di vista spaziale caratteristico di questo movimento. In ogni caso ha prodotto in questo stile delle sculture precoci e notevoli, come, per esempio El beso. Io stesso mi sono lasciato ingannare da questa illusione. Spesso ci costa capire che cosa è che ci attrae in un’opera d’arte e sempre sono stato un grande ammiratore e studioso del cubismo. Ma se devo menzionare un artista cubista che realmente ha avuto un’influenza formale diretta nella mia poesia è Piet Mondrian. Il suo impiego dei colori primari giustapposti, non mischiati, si riflette nella mia insistenza nel mantenere la purezza delle lingue che uso, e i suoi ritmi e specialità mi sono molto affini. Era una persona che riusciva a coniugare una certa austerità religiosa con l’allegria e la libertà della musica improvvisata, come lo possiamo vedere in un’opera come Broadway Boogie Woogie. Probabilmente è lo stesso anelito alla verticalità, alla spiritualità e all’essenzialità di Mondrian che mi attrae anche in Brancusi e che a lui mi unisce.
H.M.S: Ti ringrazio infinitamente per il tempo che ci hai dedicato e comunque, di quello che ci dedicherai con le tue Polyfonías e che speriamo, come ben dici i “polyfomani” possano avere ancora il piacere.
Molte grazie, Peter.
PW: Ed io ti ringrazio, Héctor, e ringrazio il genio rumeno che quest’anno mi ha offerto delle esperienze creative sempre sorprendenti e il fatto che tu con il tuo libro “Pentágono”, mi hai dato una “genealogia” e un insight estremamente utili. Brancusi, Cioran, Tristan Zara e Mircea Eliade sono stati i miei “compagni di viaggio” dal mio arrivo a Parigi nel 1970. Ma non mi era mai successo che alcuni dei miei artisti e pensatori preferiti erano tutti rumeni. Conoscevo l’origine di Brancusi, Cioran e Ionescu, ma non avevo considerato quello che potevano avere in comune. Tristan Zara e Mircea Eliade sono sempre a portata di mano nella mia casa nel villaggio medievale di Conques e non gli avevo dato una patria, anche se logicamente mi erano familiari i discorsi del Café Voltaire di Zurigo. Alla fine si sono riuniti tutti a Madrid.
Per celebrare l’occasione mi piacerebbe aggiungere un musicista rumeno: Sergiu Celebidache che dirigeva l’Orchestra Sinfonica Nazionale di Danimarca durante i miei anni di studio a Copenhague , dei suoi concerti ho dei ricordi indimenticabili. Mi piacciono tutte le arti, ma senza musica non posso vivere.